Decennale dell’Accordo di Parigi: un bilancio strategico su adattamento e resilienza
Mentre la transizione verso processi meno inquinanti ha compiuto importanti passi sulla spinta delle istituzioni internazionali, le strategie di adattamento stanno ricevendo solo recentemente una crescente attenzione, a partire dalle assicurazioni catastrofali. Le nuove priorità per i board
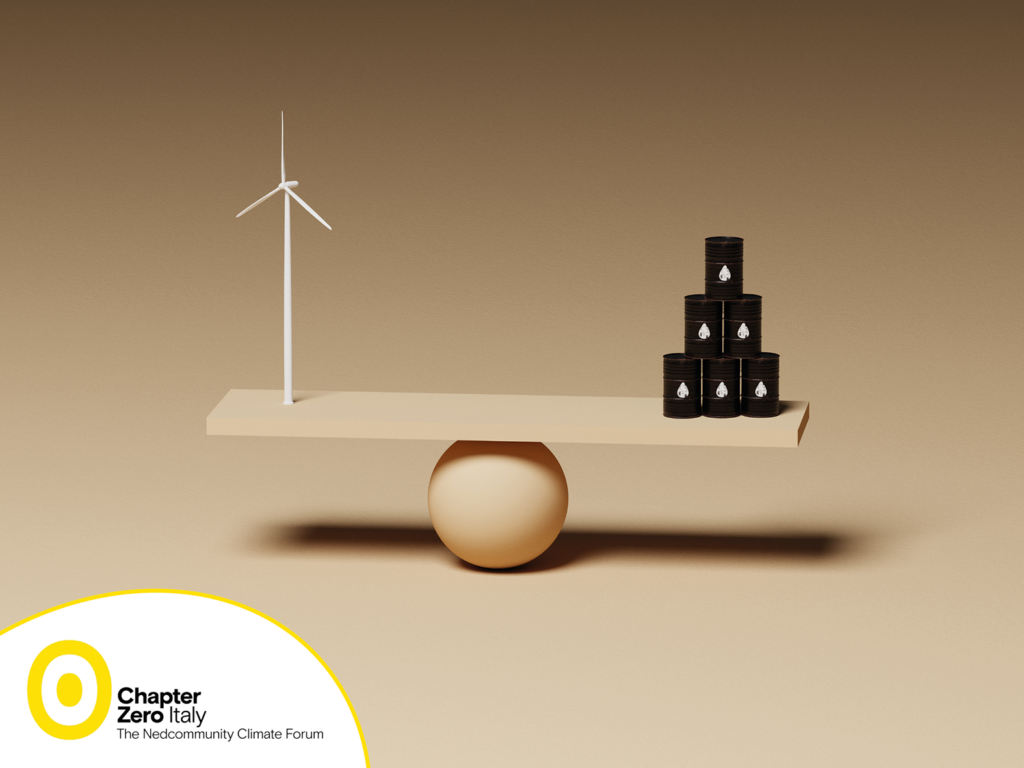 Getty Images
Getty Images
Il 12 dicembre 2025 segnerà il decimo anniversario della firma dell’Accordo di Parigi, con cui la comunità internazionale ha formalizzato l’impegno a contenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, puntando idealmente a 1,5°C. Un obiettivo ambizioso, fondato su evidenze scientifiche che dimostrano come tale soglia possa ridurre significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico.
Nel 2015, i rischi climatici erano ancora percepiti come prospettici, seppur imminenti. Oggi, a distanza di dieci anni, il cambiamento climatico è una realtà tangibile: eventi estremi, fenomeni cronici e pressioni sistemiche stanno già influenzando territori, economie e sistemi finanziari. Parallelamente, la transizione energetica globale è in pieno svolgimento, con implicazioni strategiche per tutti gli attori istituzionali.
Successi e incertezze sulla transizione
I modelli di valutazione del rischio incorporano ormai in modo sistemico le dimensioni del cambiamento climatico, distinguendo chiaramente tra rischio fisico e rischio di transizione. Tuttavia, la natura e l’evoluzione di questi rischi continuano a suscitare livelli di attenzione disomogenei da parte delle imprese e nei dibattiti all’interno dei board.
Se da un lato sono stati compiuti progressi significativi sul fronte della mitigazione – in particolare nella riduzione delle emissioni e nell’orientamento verso modelli energetici più sostenibili – dall’altro, l’adattamento e la promozione di uno sviluppo resiliente restano ambiti ancora marginali o solo emergenti nelle agende di governi e imprese. Eppure, la capacità di proteggere ecosistemi e infrastrutture dagli impatti fisici del cambiamento climatico – che si manifestano attraverso alluvioni, siccità, scioglimento dei ghiacciai e riduzione delle risorse idriche – è ormai una componente imprescindibile di una strategia di lungo termine, oltre che una potenziale fonte di opportunità e benefici.
Il rischio di transizione – strettamente legato alle specificità settoriali – è alimentato da dinamiche normative, tecnologiche e di mercato su orizzonti temporali di medio periodo, con particolare sensibilità agli indicatori di prezzo come i carbon credits e la carbon tax. La sua effettiva manifestazione dipende da scelte regolatorie e politiche strutturali, come dimostrato dalle proposte di modifica dell’EU Omnibus, il pacchetto di semplificazione della normativa europea sulla sostenibilità, che ha modificato tra gli altri provvedimenti, anche l’applicazione del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Tale episodio mette in luce quanto la traiettoria della transizione possa essere influenzata da volatilità istituzionale e da slittamenti nei processi di implementazione.
Il futuro guarda alle strategie di adattamento
Al contrario, il rischio fisico è idiosincratico, pervasivo e in accelerazione esponenziale. Non è confinato a specifici settori o aree geografiche, ma si manifesta in modo trasversale, impattando direttamente e inconsapevolmente le scelte di consumo e continuità operativa, non ha un altrettanto oggettivo indicatore di prezzo, ma, piuttosto una stima di costo evitato. La sua imprevedibilità e intensità crescente lo rendono un fattore critico per la resilienza aziendale e territoriale.
Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, tra il 1980 e il 2023 gli eventi climatici estremi hanno generato in Europa perdite economiche pari a 788 miliardi di euro, di cui 133 miliardi attribuibili all’Italia. Un dato che sottolinea la crescente vulnerabilità del territorio nazionale e la rilevanza strategica delle politiche di adattamento e prevenzione.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023), è stato introdotto in Italia un obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. A partire dal 1° ottobre 2025, le aziende sono tenute a stipulare una polizza che copra i danni derivanti da eventi meteorologici estremi – sempre più frequenti e impattanti – quali alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Pur rappresentando un passo importante verso il rafforzamento della resilienza del tessuto produttivo nazionale – e riconoscendo la crescente esposizione delle imprese italiane ai rischi fisici derivanti dal cambiamento climatico – l’obbligo assicurativo introdotto per legge si configura come uno strumento di gestione del rischio di ultima istanza.
La copertura assicurativa contro eventi catastrofali offre una protezione patrimoniale e contribuisce alla continuità operativa, ma non può sostituire l’efficacia di strategie proattive di prevenzione. La vera capacità di protezione nasce da una visione decisionale di lungo periodo, fondata su investimenti in adattamento, pianificazione territoriale, gestione dei fabbisogni e rafforzamento delle infrastrutture critiche.
L’adattamento presenta una marcata dimensione territoriale e la sua gestione efficace richiede un’interazione strutturata tra gli attori locali nei contesti in cui l’impresa opera. La riuscita delle misure di prevenzione del rischio dipende in larga parte dalla capacità di dialogare e collaborare con le autorità pubbliche, spesso responsabili dell’indirizzo strategico e della pianificazione degli interventi sul territorio.
Le nuove priorità per il board
In questo scenario, il messaggio rivolto ai board è inequivocabile: l’integrazione del rischio fisico nei processi strategici e la promozione di una cultura della resilienza rappresentano oggi una responsabilità di governance, che va ben oltre la mera conformità normativa. L’adattamento deve essere concepito come parte integrante del modello di business, influenzando in modo strutturale le scelte di investimento, al pari delle strategie di mitigazione.
Per i board e gli organi di governance, questo decennale rappresenta un’occasione cruciale per rifocalizzare le priorità, integrare l’adattamento nei piani strategici e rafforzare la resilienza istituzionale e territoriale. Non si tratta solo di gestire rischi, ma di cogliere opportunità e benefici trasformativi per garantire continuità, competitività e impatto positivo nel tempo.


